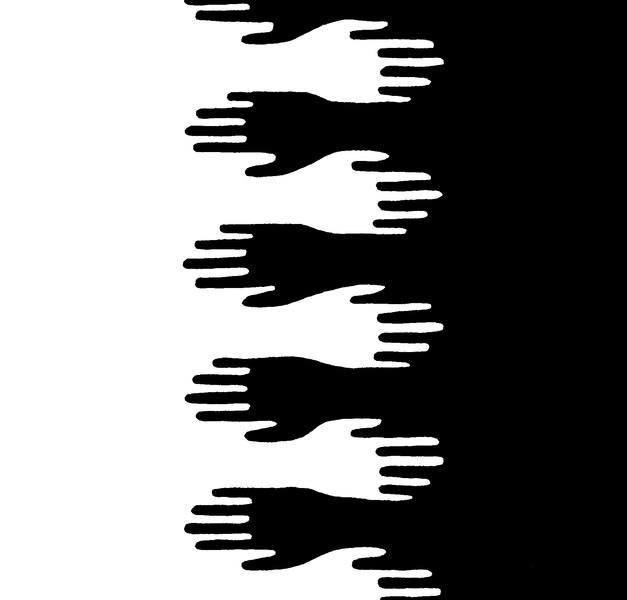Dialogo nel buio
una lezione di allestimento
Dialogo nel Buio, per chi ancora non la conoscesse, è una mostra che Andreas Heinecke ha concepito e porta da molti anni in giro per il mondo. Ma non è una mostra itinerante: in generale, in ogni nuova sede gli allestitori, spesso assistiti da Andreas e dai suoi collaboratori, sono chiamati a reinventarne l’installazione.
L’idea di base è di una semplicità disarmante.
Gruppi di otto-dieci persone, accompagnati da una guida, seguono un percorso articolato in diverse sezioni, o situazioni. Le più ricorrenti sono uno o più spazi di natura, un brano di città, interni di vario tipo, e, infine un bar.
Nella versione allestita nel 2001 nelle sale del Palazzo Reale di Milano[2], avevamo scelto come tema una gita al mare. Dunque, partendo da una grotta, si attraversava a piedi un canneto vicino al mare e si visitava il capanno della guida. Da qui, dopo un breve tragitto in una barca a motore, si raggiungeva un piccolo borgo di marinai e, infine, la visita si chiudeva al bar, chiacchierando con la guida e altri avventori.
Si tratta dunque, e sempre, di luoghi o situazioni del tutto banali.
Non è banale, però, che tutto il percorso si svolga nel buio più assoluto e che la guida sia un non vedente.
A prima vista -e l’espressione sembra fuori luogo, ma, come appunto vedrete visitando Dialogo nel Buio, anche la lingua è dominata dai vedenti, i normodotati-, nei suoi aspetti essenziali, il senso di tutto questo è evidente. Ogni visitatore ‘normale’, per una o due ore viene calato nella vita e nella condizione di un cieco e, in questa sua breve esperienza -quasi una vacanza-, viene assistito da chi cieco è davvero e sempre. L’abile e il disabile, secondo la dizione di chi ha configurato i canoni della normalità, per una volta si scambiano i ruoli.
A ben vedere, però, soprattutto nei giorni e nei mesi successivi, le inerenze, gli ‘effetti collaterali’, i riverberi che questa esperienza può indurre nell’anima e nella coscienza di chi l’ha vissuta, sono infinitamente più vasti e complessi -a volte devastanti, per molte nostre millantate certezze- di quanto non appaia durante la visita o immediatamente dopo.
Nelle note che seguono non vi è l’intenzione di esplorare o saggiare tutto l’arco delle emozioni e delle riflessioni cui Dialogo nel Buio può dar luogo. Occorrerebbero molte e differenti competenze disciplinari e troppo tempo. Qui e ora si vuole solo accennare ad alcune delle principali riflessioni che Dialogo nel Buio propone a chi si occupa di mostre e di allestimento.
L’esperienza
Parlando di Dialogo nel Buio, l’attenzione della maggior parte delle persone si ferma su un mito metropolitano -molto di moda da qualche anno, soprattutto nelle scuole di comunicazione e design- chiamato multisensorialità. Dialogo nel Buio, tutti pensano, è una mostra multisensoriale.
E’ in un certo senso un equivoco rivelatore.
In realtà qualsiasi mostra -non solo Dialogo nel Buio- è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il visitatore è calato con tutto il corpo e la mente nello spazio e nel tempo della mostra. Il tratto distintivo della visita di una mostra rispetto a tutte le altre forme di comunicazione o di apprendimento è qui: è il contatto diretto, corporeo, reale con oggetti reali. Non vi sono riproduzioni, reali o virtuali, ma oggetti fisici, e il rapporto con tali oggetti è un rapporto fisico.
Se ci ostiniamo a parlare della mostra come di una forma di comunicazione visiva è solo perché la vista è ancora il senso dominante nella nostra cultura. Da questo equivoco, che ha il fascino proprio di ogni atto di sottrazione, nasce, ad esempio, un altro mito: il museo virtuale. Il museo virtuale è quasi come un libro: strumento fondamentale di trasmissione della conoscenza, ma inconfrontabile con una mostra, perché, appunto, non offre il rapporto fisico con gli oggetti. Quasi come un libro, perché sul monitor -come nella mostra, ma per ragioni diverse- trovarsi cento pagine da leggere è quanto meno scoraggiante.
Domanda: è così importante il rapporto fisico? Risposta: perché si fanno le fiere? Perché gli industriali spendono miliardi per allestire stand e showroom? Perché per vendere, per convincere, non basta un catalogo, non basta la riproduzione virtuale o fotografica di un oggetto.
Dialogo nel Buio fa capire –a chi ancora avesse dei dubbi in tale materia-, dunque, per prima cosa, che l’oggetto dell’allestimento non è tanto l’oggetto mostrato, che può essere anche banale, quanto, piuttosto, l’esperienza sensibile che dell’oggetto mostrato viene proposta al visitatore. Il progetto dell’allestimento è il progetto di un’esperienza, dell’esperienza del visitatore.
Media e apprendimento
Tornando alla presunta multisensorialità di Dialogo nel Buio, è del tutto naturale -in senso stretto- che laddove la vista non può operare intervengano gli altri sensi: l’udito, il tatto, l’olfatto e, se possibile, il gusto. In termini tecnici, in tal caso si parla di sensi vicarianti. Il cervello cerca di ricostruire le informazioni che proverrebbero dal senso mancante con le informazioni disponibili -e accentuate- dei sensi rimasti. Ciò accade perché forse il cervello cerca comunque e sempre di costruire un’immagine del mondo con tutti -quali che siano- i mezzi di cui dispone.[3]
Ma il punto importante è un altro: il punto è la sottrazione della vista, proprio il senso dominante nella cultura contemporanea, o forse di ogni cultura dopo l’invenzione della scrittura. Essere costretti a usare esclusivamente gli altri sensi non solo modifica la nostra percezione delle cose, ma modifica anche il senso, il significato delle cose. Questo, alla radice, è il grimaldello con cui Dialogo nel Buio rompe tutti i codici.
McLuhan ci ha insegnato che il mezzo di comunicazione determina il messaggio, in qualche modo coincide con il messaggio. In altri contesti -nella fisica, nella filosofia della scienza- è ormai acquisito che la forma e le circostanze della domanda implicano la risposta.
Questo appare con tutta evidenza anche in Dialogo nel Buio, perché nel buio sono diverse -o apparentemente inconsuete- le procedure di apprendimento, di acquisizione della conoscenza. Si attivano, o diventano determinanti, altre procedure, perché sono diversi i contesti, la mappa dei riferimenti mentali in cui caliamo le cose stesse.
Facciamo un esempio: pensiamo a una scultura. Di una scultura, la vista consente -ai vedenti– una preliminare visione d’insieme. Poi, successivamente, se vogliamo, di essa noi vedenti possiamo passare ad esaminare i particolari, i dettagli, parte per parte. Schematicamente, si può dire che il processo muove dalla sintesi -la visione d’insieme- all’analisi. La mappa dell’oggetto precede l’analisi.
Se invece non vediamo, siamo costretti a percorrere con le mani, col tatto o anche muovendoci nello spazio, tutta la superficie della scultura. Dobbiamo partire dai particolari per costruire con la memoria e l’immaginazione la forma complessiva, l’insieme.
Schematicamente, si può dire che il processo muove da una visione analitica verso una possibile sintesi, verso una qualche forma di riconoscimento. La mappa dell’oggetto è successiva all’analisi.
In realtà, le mappe dei riferimenti mentali -e non soltanto- sono una cosa molto più complessa. Semplificando, poiché siamo inseriti in una cultura, qualsiasi cosa cada sotto i nostri sensi viene inserita, in una griglia -in una specie di mappa- presente nella nostra memoria, formata dalla nostra memoria.
Occorre però osservare che la memoria agisce sia per i non vedenti che per i vedenti. Quando noi vedenti vediamo un oggetto, la nostra memoria lo riconosce, e associa immediatamente la forma che vediamo a precedenti esperienze anche tattili.
Può chiarire questo punto un esperimento, di alcuni decenni fa, su ciechi dalla nascita cui, grazie ai progressi della medicina, era stata ridata la vista: posti di fronte a un cubo e a una sfera, non erano in grado di riconoscerli se non toccandoli.
La differenza reale nei processi mnemonici di vedenti e non vedenti, sta nel fatto che i vedenti usano normalmente molto meno -e soprattutto meno consapevolmente- dei ciechi la memoria specifica degli altri sensi. Usano meno -o meno consapevolmente- la sinestesia, ossia l’azione combinata di tutti i sensi.
Il problema, qui, è che la consapevolezza è il fondamento della coscienza, o forse coincide con essa. Se non siamo consapevoli, se non riconosciamo, addirittura non vediamo: semplicemente non conosciamo, non sappiamo. Di converso, si potrebbe dire che possiamo conoscere solo quello che riconosciamo, vale a dire quello che riusciamo a inserire in una mappa, in un contesto che dia un significato, un senso, un possibile nome a quello che abbiamo di fronte. Forse è questa la ragione per cui non possiamo inventare animali inesistenti, se non montando a caso pezzi di animali esistenti.
Per comprendere cosa siano le procedure di acquisizione della conoscenza, possiamo fare un altro esempio: pensiamo al modo con cui giudichiamo gli altri, le persone.
Al buio, in assenza di visione, il fascino o la bellezza di una persona rispondono a canoni ben diversi da quelli cui fotografie, cinema o televisione ci hanno abituato. Al buio, gli strumenti di valutazione sono altri, come il suono della voce, il tono, l’odore della pelle, il modo di toccare. Il “chi è?” non è più legato a un look, a un’immagine visiva, ma ad altri tipi di immagine mentale.
Ovviamente, la voce o il modo di toccare o l’odore della pelle, valgono anche per i vedenti. L’esigenza primordiale di dipanare il mistero dell’altra persona, e dunque le modalità e i mezzi di riconoscimento del suo carattere, della sua indole, a parte l’aspetto visibile, in realtà non sarebbero diversi tra vedenti e non vedenti, ma il peso di ciò che non vediamo, delle informazioni che ci vengono dagli altri sensi, al buio, in assenza di visione, diventa infinitamente maggiore.
Per chi fa mostre, Dialogo nel Buio pone dunque in evidenza altri elementi determinanti, specifici del progetto allestitivo.
L’allestimento, operando con e su i mezzi di presentazione e rappresentazione dell’oggetto esposto, opera sul senso e sui significati dell’oggetto stesso. L’allestimento non è mai, né può essere, neutrale.
Costruendo contesti, sfondi e riscontri tra gli oggetti esposti, l’allestimento disegna una mappa attraverso la quale conoscere e riconoscere l’oggetto.
Vis comica
Un dato implicito in tutto questo è il ruolo dell’attenzione.
Chi, visitando Dialogo nel Buio, viene temporaneamente privato della vista, è ovviamente costretto, per tutto il tempo della visita, ad un’attenzione spasmodica, totale: per non cadere, per capire dov’è, cos’ha di fronte, per riconoscere cose e persone.
Anche l’attenzione, dunque, non solo l’uso dei sensi vicarianti, contribuisce a modificare il senso, il significato delle cose, poiché nulla appare ovvio, scontato. L’attenzione cerca di portare alla coscienza tutti i dati disponibili.
E questa è un’altra lezione di Dialogo nel Buio.
La vis comica, la capacità di un allestimento di coinvolgere il visitatore è, nella sostanza, la capacità di tener desta la sua attenzione, la capacità di intervenire, alterare, rompere tutti i modi di presentazione e rappresentazione che rendano ovvio, e dunque invisibile, l’oggetto esposto.
Non si tratta di essere originali ad ogni costo. Se in una mostra collettiva d’arte contemporanea, si ammassano opere ognuna delle quali vuole a suo modo rompere le regole, il messaggio si azzera, tutto diventa uguale a tutto.
Al contrario, nell’allestimento si tratta di sviluppare, di far emergere le qualità specifiche di ogni oggetto esposto, gli elementi che rendono unico quell’oggetto, o la personalità dell’autore, o, nel caso di prodotti industriali, il brand del produttore.
E ancora, la memoria di una cosa o di un evento si attiva quando la cosa o l’evento diventano oggetto di un’esperienza consapevole, quando dobbiamo rendercene conto, vale a dire quando associamo la cosa o l’evento ad altre cose o eventi, inserendoli appunto in una mappa, in una rappresentazione.
Infine, qui l’attenzione ha una qualità speciale: è -non può che essere- condivisa. Al buio, il riconoscimento di cose e il riconoscersi reciproco delle persone sono atti di interazione comunicativa, o, più esattamente, atti interattivi di rappresentazione delle cose e delle persone presenti. E’ in questa condivisione obbligata, che si invertono i ruoli tra abile e disabile, tra cieco e vedente, è lì che si attivano procedure di apprendimento diverse o inconsuete, che diventa necessario affidarsi gli uni agli altri.
Ma, in realtà, qualsiasi rappresentazione -e qualsiasi mostra- è tale, funziona, se è condivisibile, se cioè è atto sociale o collettivo di riconoscimento del mondo e di noi nel mondo. Dialogo nel Buio semplicemente ci obbliga a rendercene conto.
La narrazione
Torniamo al primo esempio, ma non parliamo di una scultura: parliamo dello spazio.
Ad Amburgo, dopo aver sperimentato per la prima volta il percorso di Dialogo nel Buio –nella prima installazione permanente-, Andreas a sorpresa -e, come poi capimmo, provocatoriamente- ci chiese di disegnarne a memoria la mappa. Ovviamente, ci fu possibile soltanto indicare sommariamente la serie delle ‘stazioni’.
La lezione potrebbe fermarsi alla constatazione che se un vedente non può vedere, se non ha una visione d’insieme, il criterio d’ordine principale, se non l’unico, diventa la successione temporale, cioè una sequenza lineare, il filo d’Arianna del percorso che ha seguito.
Ma non è così. La lezione più generale è che l’unitarietà di un’esperienza -l’esperienza di un oggetto o di un luogo- non è data -o almeno non soltanto- da una visione prospettica, dalla contestualità di più cose, ma può essere data anche da un racconto, da una narrazione che lega tra loro quelle cose, e che così facendo le rende memorabili. Si potrebbe dire che la mappa che connette le cose e che ne consente, o facilita, la memoria, può essere non solo spaziale, ma anche temporale, oppure si potrebbe dire che la dimensione tempo è fondamentale anche per comprendere lo spazio.
E’ per questo che l’installazione a Palazzo Reale, a differenza delle precedenti, fu progettata -appunto- unitariamente come una gita, senza soluzioni di continuità tra una situazione e l’altra. Separare ogni ambiente dagli altri comporta il rischio di perdere il senso complessivo del viaggio -e della visione- nel buio, o –annullando pathos e emozione- di esorcizzare lo spessore dell’esperienza, riducendola, talvolta, alla gara tra chi riconosce per primo una cosa o l’altra.
Questo possibile ruolo -o potere- della narrazione nello spazio appare anche nella differenza tra la prospettiva rinascimentale e la prospettiva gotica, medioevale.
In estrema sintesi, entrambe operano sulla contestualità. Ma la prima, rinascimentale, giocando con l’illusione dello spazio, ordina le cose e i soggetti compresenti, e la loro dimensione, in ragione della loro -apparente- distanza dall’osservatore, riproducendo l’effetto ottico proprio della visione umana, binoculare. La seconda, invece, stabilisce ordine e dimensioni in ragione della gerarchia delle cose e dei soggetti, in ragione cioè dell’importanza e del ruolo che esse assumono in una narrazione. Per dirla con una metafora, la prospettiva rinascimentale è un’immagine statica, congelata: è un’istantanea, come una fotografia. La prospettiva gotica, come in una certa misura lo spazio dei non vedenti, è fondata sulla successione degli eventi -delle sensazioni-, è fondata sul tempo: è dinamica, come un film.
Da qui potrebbero partire molti ragionamenti, che per ora possiamo riassumere soltanto in due brevissime osservazioni, due spunti per riflessioni future.
Il sistema delle differenze tra la staticità della prospettiva rinascimentale e la dinamicità della visione gotica, tra lo spazio dei vedenti e quello dei non vedenti, mostra analogie fortissime con la differenza tra le culture fondate sulla scrittura e quelle fondate sull’oralità. Non a caso, poiché la scrittura a sua volta si fonda sulla visione, mentre l’oralità sull’udito. In una sequenza possiamo fermare un’immagine visiva, ma non è possibile fermare un suono. Il suono è un’azione, e se si ferma, semplicemente non c’è. Lo spazio che i non vedenti ci mostrano è lo spazio degli eventi.
L’importanza della narrazione come legante, ossia come strumento di orientamento e di memorizzazione, e/o come strumento di realizzazione di un orizzonte di senso, è evidente in molte forme di trasmissione della conoscenza che sembrano riconducibili all’oralità. Ne sono esempi la via crucis, usata per trasmettere e legare tra loro alcuni elementi fondativi della teologia cristiana, o certi miti, come le cosmogonie, ma anche, infine, molte favole, come Cappuccetto Rosso o Biancaneve, inventati per educare, per trasmettere principi morali o codici di comportamento, a bambini o ad adulti.
E questa è un’ulteriore lezione di Dialogo nel Buio sull’allestimento. Il percorso di una mostra, articolato tra rotonde e gallerie[4], vale a dire nelle due logiche distinte ma intrecciate della contestualità, da un lato, e della sequenza lineare, dall’altro lato, è anche la forma di una narrazione, e come tale, come un racconto, come la sceneggiatura di un film può essere progettato, comprendendo che i luoghi e i tempi della successione vanno calibrati e scanditi, comprendendo che il protagonista del racconto è il visitatore.
Simulazione e rappresentazione
Tornando al tema dell’esperienza del visitatore, vale a dire all’oggetto principale della progettazione, vi è un’altra cosa da dire.
Al momento di progettare l’installazione di Dialogo nel Buio a Palazzo Reale, ritenni che si dovesse costruire una rappresentazione, più che una simulazione. Che al visitatore fosse evidente, ad esempio, che il verso dell’anatra nel canneto era una riproduzione, non una realtà.
Perché?
Simulare deriva da simul, che sta per “insieme”, parente di similis, cioè “simile”. Simulare significa dunque “fare il simile”, “fingere con arte -dunque anche maliziosamente- ciò che realmente non è”, ovvero “far apparire qualcosa che non è”, “far finta”. Una simulazione è un atto legato all’oggetto, viene subìta dall’osservatore, implica una sua passività.
Rappresentare deriva da re, che significa “di nuovo”, e praesens, presente. Rappresentare significa quindi “rendere presenti cose assenti”, cose cioè passate o lontane, “esporre in un modo qualsiasi figure o fatti dinanzi agli occhi del corpo o della mente”. Significa, perciò, sviluppare qualcosa che è nella mente, nella memoria del visitatore.
A teatro, ad esempio, rappresentazione non significa riprodurre una copia (falsa) della realtà, ma evocare il senso (vero, o attribuito) di quella realtà. Dunque, una rappresentazione non inganna l’osservatore, ma lo coinvolge, implica la sua partecipazione attiva. La rappresentazione è un atto creativo, che coinvolge sia l’autore sia l’osservatore.
Dialogo nel Buio semplicemente non ha senso senza la partecipazione attiva dei suoi visitatori, e ci fa capire, una volta di più, che una mostra ‘funziona’ solo se è stata pensata e realizzata come una forma di rappresentazione.
La lezione
Non è affatto paradossale che le osservazioni, i ripensamenti, le revisioni su tutto l’universo del mostrare che Dialogo nel Buio comporta, siano nello specifico della mostra l’analogo -molto riduttivo- delle osservazioni, dei ripensamenti, delle revisioni cui Dialogo nel Buio ci costringe su tutta la nostra ‘visione’ del mondo.
Il messaggio più profondo e più importante di Dialogo nel Buio è che la nostra visione del mondo, la visione che noi vedenti diamo per ovvia, scontata, non è l’unica possibile.
I non vedenti ci indicano un’altra, e dunque infinite altre visioni del mondo, tutte di pari dignità.
I non vedenti –e Dialogo nel Buio- possono farci comprendere i limiti della nostra visione del mondo, i nostri stessi limiti.
Poter cambiare modo di ‘vedere’, come abbiamo visto, significa poter cambiare i significati delle cose, o scoprirne di nuovi o sconosciuti, e impone un’attenzione costante. Nulla rimane ovvio.
Alla fine, Dialogo nel Buio è la più bella lezione che io conosca contro l’arroganza di chi ritiene di possedere la verità, contro ogni forma di integralismo.
[1] Questo testo è la trascrizione dell’intervento ad un seminario sulla luce, nel 2003, organizzato da Pier Paride Vidari nella Facoltà del Design del Politecnico di Milano.
[2] La mostra, voluta e organizzata da Franco Brambilla, fu allestita, su progetto di Nicola Marras, Pier Paride e Federico Vidari, dalla Diade Allestimenti di Luciano Paz.
[3] Per avere un’idea della straordinaria plasticità del cervello umano, e per comprendere che, cercando senza pregiudizi, non troveremo una, ma mille, infinite forme di intelligenza delle cose, può essere illuminante -oltre che allarmante e commovente- la lettura di L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Oliver Sacks, Adelphi, Milano 1985.
[4] Circa i concetti di rotonde e gallerie, cfr. anche, di chi scrive, Scenari del mostrare, in “Modo” n°205, luglio-settembre 2000, pag. 40.